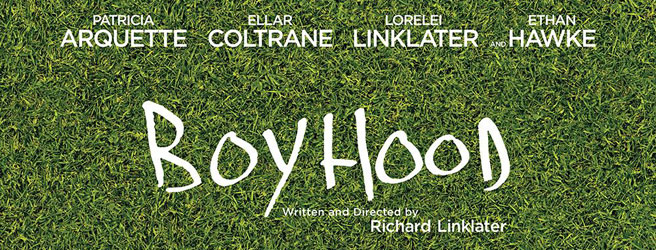Sezionando l’occhio di ogni regista si scoprono miriadi di elementi che compongono la sua visione del mondo. Con esami più dettagliati si riesce a tratteggiare la fenomenologia di questa, una sorta di essenza se vogliamo.
Direi ad esempio che Ridley Scott è il regista del bagnato-caliginoso, che Cronenberg è il regista del carnoso, dell’unto, dell’appiccicaticcio e che molti lo sono del patinato ed imbellettato.
Di Richard Linklater scrivo, invece, che è il regista dell’identificazione, della posterizzazione, l’effetto applicabile ad un’immagine per cui questa viene compressa riducendone i livelli di colore ed aumentandone il contrasto.
In pratica: una serie di ditate su un vetro. “Boyhood” è la testimonianza più evidente dal momento che racconta quella fase critica di ogni individuo che parte dall’infanzia, passa dall’adolescenza e muta alle prime avvisaglie di maturità.
Gli attori sono sempre gli stessi fondendo i tempi del film con quelli della vita reale. Cioè Linklater ha preso un bambino e lo ha inquadrato nella crescita seguendo i tempi del suo fisico.
Un’avventura favolosa per un regista e riflessiva per il pubblico costretto a ripensare a quel tratto di vita dove si capisce molto dell’esterno ma nulla del proprio interno. I colori sono pochi ma ben contrastati ed in equilibrio dato da una leggera desaturazione.
Tutto l’opposto di “A Scanner Darkly” nel quale la brillantezza e l’eccessivo contrasto servono a disindividuare. Tutto l’opposto di un contesto cinematografico in maschera.